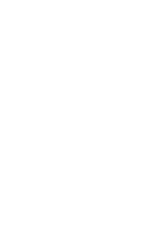A nessuno piace stare male ed una sofferenza di qualche tipo è ciò che ha probabilmente spinto ognuno di noi alla ricerca di un percorso di crescita personale o spirituale in un momento particolarmente difficile della nostra vita. In quei momenti, ciò che alimenta la nostra ricerca è il desiderio di trovare una “soluzione” che ci permetta di uscire dal nostro malessere.
Maggiore è il malessere e naturalmente maggiore è anche il desiderio di uscirne il prima possibile. Con questo approccio, per alcuni di noi, una forma terapeutica o di crescita personale e spirituale rappresenta ciò che potrebbe porre fine ai nostri disagi. Pertanto, la fretta di “risolvere” queste problematiche è proporzionata all’intensità del disagio che percepiamo.
Immagina che per parole come “soluzione” e “risolvere” io stia facendo il gesto dei virgolettoni con le dita, poiché ciò di cui ti parlerò oggi riguarda proprio la nostra tendenza a voler eliminare ciò che viviamo con difficoltà e che dunque la nostra mente decide che va rimosso il prima possibile. Come vedremo nel corso di questo episodio, ogni volta che opponiamo resistenza e rifiutiamo qualcosa che avviene dentro di noi, generiamo sofferenza e amplifichiamo enormemente il malessere già presente.
A volte abbiamo a che fare con disturbi che non sappiamo quanto dureranno o con condizioni con le quali sappiamo che dovremo convivere per il resto della nostra vita. Anche quando si tratta di disturbi non gravi, se questi vanno a scontrarsi con l’immagine che abbiamo di noi stessi e con i programmi che avevamo fatto per la nostra vita, possiamo entrare in profonde sofferenze perché non accettiamo che le cose non vadano come avevamo deciso dovessero andare.
Nella maggior parte dei casi che ho seguito in questi anni, in cui una persona portava una determinata tematica di tipo fisico, emozionale, psicologico o spirituale, la resistenza ad accettare la propria condizione, era in assoluto ciò che generava la maggior parte del malessere. Paradossalmente, lo era molto più della tematica stessa! E poiché l’obiettivo concordato era quello di aiutare la persona a stare meglio, piuttosto che a risolvere la tematica in sé, che magari sarebbe potuta durare ancora mesi o anni, il lavoro si è concentrato soprattutto sull’aiutare la persona ad accettare il fatto che in questo momento della propria vita, questo era ciò con cui doveva avere a che fare. Lavorandoci e curandosi il necessario, ma comunque accogliendo quanto più possibile ciò che faceva parte della propria vita in quel particolare momento.
Poiché tutti, in un modo o nell’altro, sperimentiamo questo tipo di resistenza e sofferenza, con questo articolo, mi auguro di poterti aiutare a comprendere che qualunque sofferenza tu stia vivendo, la scelta di accettare la tua esperienza è la chiave per portare più serenità nella tua vita.
La Ricerca della “soluzionE”
Alcuni di noi, nel corso della propria vita, vivono periodi talmente neri che vengono letteralmente chiamati “la notte buia dell’anima”, quindi fasi estremamente difficili con malesseri profondi. In queste situazioni, ciò che aumenta la sofferenza è il fatto che al malessere si aggiunge anche la frustrazione quando sentiamo di non avere ancora trovato qualcosa di efficace per la nostra condizione specifica, che sia una pratica spirituale, una disciplina terapeutica, una modalità di crescita personale o qualunque altra cosa che ponga fine a questo patimento.
In una società che, attraverso vari mezzi di comunicazione quotidianamente ci offre immagini di successo, bellezza, salute, forza, gioia e felicità, questa nostra sofferenza risulta piuttosto dissonante. E anche il mondo della spiritualità e crescita personale non sono esenti da questa tendenza a voler mostrare per lo più ciò che è bello e positivo. Che siano social media, YouTube, tv o riviste, in ogni momento essi alimentano un ideale di perfezione che è ben lontano dalla realtà. Tenendosi alla larga dalle loro controparti negative come fallimento, bruttezza, malattia, debolezza, tristezza/dolore ed infelicità, c’è un voler mostrare solo le cose belle e distogliere l’attenzione dal malessere, che risulta essere qualcosa di indesiderabile. Inevitabilmente, guardandoci intorno e non ritrovandoci in questa realtà di contentezza, sentiamo che c’è qualcosa che non va in noi se non stiamo altrettanto bene.
Ci assale un senso d’inadeguatezza che si va ad aggiungere al nostro malessere profondo. Guardandoci intorno e paragonandoci a chi ci circonda, vediamo quanto meglio di noi sembrino stare gli altri (e sottolineo “sembrino”) stare gli altri, e quindi ci demoralizziamo. Crediamo a questa illusione e ci convinciamo di non essere capaci di stare meglio, qualunque tecnica, metodologia o terapia stiamo utilizzando in questo momento. Vedere quanto bene sembrino stare loro e quanto male continuiamo a stare noi, nonostante quante ne stiamo provando, ci fa sentire da meno e ci fa salire un senso di angoscia perché non sentiamo di valere quanto gli altri. Oltre al malessere del nostro disagio, dunque, si va ad aggiungere il senso di auto-svalutazione e da dentro emerge quella voce che ci dice:
“Se sei come loro, vai bene; altrimenti, no.”
Se vuoi conoscere meglio questa voce interiore, puoi ascoltare l’episodio intitolato “Il Giudice Interiore e Come Trasformarlo”.
Un po’ per questo senso di poco valore, un po’ per una questione di orgoglio e di immagine personale, un po’ per una paura ancestrale che il nostro malessere rischia di farci allontanare dal villaggio perché non siamo abbastanza sani e forti come tutti gli altri, un po’ per tutti questi motivi, scegliamo di isolarci per evitare di essere visti in questo stato.
Ma poiché spesso non possiamo improvvisamente sparire tout court, in quei contesti nei quali non possiamo fare a meno di interagire con altre persone, iniziamo ad usare varie maschere per dissimulare la nostra reale condizione. Tre delle più utilizzate in questi casi sono la maschera della serenità, la maschera della salute e la maschera della positività. In realtà queste maschere potremmo starle usando da sempre, solo che adesso diventano un po’ più faticose da tener su rispetto a una volta, che erano molto più naturali e credibili. Di fatto, ci mostriamo più ottimisti e di stare meglio di quel che realmente stiamo. Lo facciamo sia perché non vogliamo che gli altri si accorgano della profondità del nostro malessere, ma anche perché è considerato quasi maleducato alla domanda “come stai” rispondere: “male, grazie”. Mettere un’altra persona in una condizione di tale imbarazzo è quasi criminale nella nostra società così emotivamente interdetta.
Nella nostra cultura siamo particolarmente a disagio con il malessere altrui. Frasi come “su, su, non essere triste” oppure “dai, non piangere”, o “non aver paura” o “non c’è bisogno di arrabbiarsi”… fanno ormai parte del nostro vocabolario quotidiano. Invitiamo letteralmente l’un l’altro a non provare, o quantomeno non mostrare quelle emozioni che abbiamo collettivamente etichettato come “negative”. Un po’ per l’erronea convinzione che queste emozioni, se lasciate libere di scorrere, faranno danni irreparabili internamente ed esternamente, un po’ perché siamo noi i primi a non saper bene come gestire queste emozioni dentro di noi. Dunque, quando vengono espresse da qualcun altro, ci lasciano completamente spiazzati.
Per evitare di sentire queste emozioni scomode, uno strumento molto utilizzato anche negli ambienti spirituali e di crescita personale, è quello del pensiero positivo. Il pensiero positivo è un’utile modalità che ci invita ad essere ottimisti in relazione alla nostra vita e al nostro futuro. Al contempo, troppo spesso diventa un inconscio escamotage per prendere le distanze da quelle emozioni che abbiamo bollato come “negative”. Dunque, quando dentro di noi si presentano emozioni scomode, indossiamo una maschera di positività nella speranza di non sentirle. Non è quindi raro interagire con persone la cui “positività” risulta un po’ forzata.
Online è molto diffusa questa credenza collettiva che essere solari sia molto preferibile all’essere seri o anche semplicemente neutri. Per essere più popolari ed accattivanti, nei social mettiamo foto con sorrisi a 32 denti e nei video online, chi parla spesso ostenta allegria e sorrisi che danno più che altro l’impressione di spasmi muscolari.
In questi casi il nostro cervello può convincersi che la persona che abbiamo davanti sia realmente positiva e allegra. Al contempo, a livello viscerale sentiamo che c’è qualcosa che non ci convince e che non sentiamo autentico. Per carità, cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno non è di per sé un comportamento poco genuino, ma al contempo il forzare noi stessi a distogliere l’attenzione da ciò che è naturale ma non ci piace, è un comportamento evitante. Quindi, sebbene non sia raccomandabile crogiolarsi costantemente nei propri malesseri, è altrettanto sconsigliabile evitarli ogni qualvolta essi si presentino. Questo non solo non aiuta da una prospettiva puramente terapeutica, ma va ulteriormente ad alimentare la credenza che il positivo è bene, mentre il negativo è male.
Da qui il passo è breve al convincersi che stare bene è giusto, mentre star male è sbagliato, soprattutto se, guardandoci in giro, c’è un sacco di gente che finge di stare bene in maniera piuttosto convincente. Di conseguenza, quando stiamo male, oltre al malessere c’è anche questa illusoria angoscia di stare sperimentando qualcosa di innaturale e sbagliato, che ci rende troppo fragili, che ci fa correre il rischio di venire discriminati e che sostanzialmente mette a repentaglio la nostra permanenza all’interno della tribù.
I nostri malesseri diventano dunque i nostri principali nemici perché mettono a rischio la nostra sicurezza sociale e rappresentano quei limiti che vanno a tutti i costi eliminati.
E in una cultura che, anziché cercare di comprendere, è piuttosto intenta a combattere ed eliminare tutto ciò che reputa sbagliato, come la morte, la malattia ed i difetti, anche i limiti entrano nel mirino del nostro accanimento terapeutico.
Dunque questi limiti, che spesso ci accompagnano da buona parte della nostra vita, cominciamo ad accusarli di essere quei fardelli che ci impediscono di raggiungere quel benessere fisico, mentale, emozionale, spirituale, professionale o economico che da sempre inseguiamo. Essi vengono visti come debolezze che dobbiamo eradicare dal nostro sistema, poiché sono le dirette responsabili di ciò che ci preclude il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Questo approccio perfezionistico lo ritroviamo dovunque: dal lavoro allo sport, dalle relazioni all’arte. Nell’ambito di percorsi di crescita personale e spirituale, seppur ponendo meno l’accento sul fattore esteriore di bellezza, denaro e successo, e virandolo più sul “successo interiore”, anche lì troviamo questa modalità. Attraverso video, libri, corsi, pratiche e discipline, veniamo guidati nell’applicazione di tecniche e metodologie finalizzate al raggiungere vari obiettivi, che riguardano salute, pace interiore, successo, felicità, relazioni appaganti o qualsiasi altra cosa possiamo desiderare. L’invito di fondo, però, è quasi sempre quello di superare i nostri limiti e finalmente esprimere il nostro ‘vero potenziale’.
In quest’ottica, forza, volontà, costanza e determinazione sono dunque quelle qualità che ci permetteranno di raggiungere felicità e benessere. In forte antitesi ad esse, fragilità, vulnerabilità, indecisione e mancanza di energia sono quei “difetti” che ne ostacolano il raggiungimento. Che sia conscio oppure no, non è difficile immaginare come questo modo di vedere le cose ci porti a sentirci nei confronti delle due categorie: amiamo quelle qualità che pensiamo ci portino ad essere felici ed odiamo quei difetti che siamo convinti ci tengano incagliati nella nostra sofferenza.
Non è nemmeno difficile comprendere il livello di pressione che abbiamo dentro. La posta in palio è il nostro benessere personale, un montepremi astronomico che inseguiamo da tutta una vita. Dunque la possibilità di fallire porta con sé un rischio enorme e questo fa sì che internamente ci sia tensione ed una mastodontica aspettativa. La credenza che trasformare noi stessi eliminando ciò che ci zavorra, ci renderà felici, però, ci ha anche portati a fare inconsciamente questo ragionamento:
“Poiché non ne posso più di stare male, adesso che ho finalmente trovato [inserisci una pratica a scelta], devo dedicarmi ad essa quanto più possibile per far cessare questa sofferenza.”
Non ne possiamo più di stare male, dunque nel momento in cui sentiamo di aver trovato la “soluzione”, sentiamo di doverci buttare a capofitto convinti che essa risolverà ogni nostro problema.
Al contempo, però, l’amletico dubbio che quasi sempre accompagna questo ragionamento, anch’esso a livello inconscio è:
“Ok, ma nel frattempo? Cioè, parliamoci chiaro: se sarò felice solo quando avrò raggiunto quegli obiettivi, oggi… e tutti i prossimi giorni finché non arrivo a destinazione… sono quindi destinato ad essere infelice?? 😱”
Questa realizzazione ci lavora dentro, andando ad aumentare la pressione interna e la nostra ansia da prestazione. Sentiamo di avere fretta, perché vogliamo uscire quanto prima dalla nostra condizione perché fintanto che restiamo qui, siamo condannati a soffrire.
Partiamo quindi a 200 all’ora, determinati a coprire tutte le tappe più in fretta possibile.
Ben presto, però, ci rendiamo conto che le cose non vanno spedite come avremmo voluto. Iniziamo a vivere stati di grande frustrazione perché ci sono un sacco di ostacoli, soprattutto interni. Abbiamo resistenze, pigrizie, vecchi sistemi di credenze che, ripetutamente, si frappongono tra noi e i nostri obiettivi. Diventa una lotta intestina nella quale litighiamo quotidianamente con noi stessi, perché vorremmo essere “meglio” di quelli che realmente siamo.
Nei video che troviamo online, chi propone queste pratiche si dimostra disinvolto, sereno, ricco (dentro e/o fuori) ed in qualche modo “arrivato e risolto”. Noi, che stiamo facendo fatica anche ad uscire dai blocchi di partenza, ci sentiamo profondamente inadeguati e che mai potremo arrivare al loro livello. Se ogni passo su questo cammino è così faticoso, come possiamo pensare di arrivare mai ad essere come queste persone?! Questi sono terapeuti, maestri, gente avanti… non ce la faremo mai!
In merito a questo, mentre buttavo giù le prime bozze di questo episodio, ho preso un appunto a riguardo che ritenevo utile per chiarire una cosa importante. È in francese, ma credo non avrai difficoltà a comprenderlo ed è questo:
“Anch’io c’ho mille cazzi, così come tutti i terapeuti che accompagno da 15 anni”
Ora, possiamo disquisire sul numero esatto se sono mille o qualcuno di meno, ma la sostanza è comunque quella: ogni terapeuta, maestro o guru (sì guru) è comunque un essere umano. Questa nostra ossessione col perfezionismo ci porta a voler idealizzare questo tipo di figure, vedendole come risolte, ma in realtà hanno a che fare con esattamente le stesse tematiche nostre, a volte anche di più e da più tempo, il che potrebbe benissimo essere il motivo per cui molti di essi hanno scelto proprio di diventare terapeuti.
Ricordo quando stavo facendo la mia formazione professionale e la fondatrice della nostra scuola, Barbara Brennan, che apriva ogni settimana di intensivo con un incontro in una grande sala per darci il benvenuto… e davanti a centinaia di studenti, molti dei quali la vedevano come una semi-divinità, ci raccontava dei suoi problemi personali, come ad esempio quelli che aveva con l’attuale marito, che non era neanche il primo o il secondo, non ricordo. Ciò che però ricordo è quanto bene mi ha fatto scoprire che anche lei, che all’epoca aveva 70 anni suonati, stesse avendo a che fare con problemi relazionali esattamente come me e tanti altri.
Però, finché non realizziamo che ognuno ha le proprie tematiche, pensiamo di essere gli unici con queste difficoltà. Ci sentiamo affranti e ci assale un senso di fallimento. Dubitiamo di avere le qualità necessarie per portare a termine i nostri obiettivi. Quindi, in base alla nostra capacità di perseveranza, dopo qualche settimana/mese/anno dall’inizio di una particolare pratica, ci sentiamo ancora peggio di quando avevamo cominciato. Poiché l’obiettivo iniziale era proprio quello di stare meglio, ognuno reagisce in maniera diversa a questa cosa: c’è chi insiste, c’è chi si cerca un altro terapeuta o un’altra modalità sperando sia più efficace, c’è chi si rassegna e molla.
Ora, credo che in vari momenti della nostra vita, tutti abbiamo sperimentato ciascuna di queste tre fasi. Ma facendo un piccolo rewind della situazione e tornando all’inizio di essa, possiamo scoprire che c’è un solo, semplice motivo per il quale tutta questa esperienza, strada facendo, è diventata così stressante per noi: perché abbiamo vincolato il nostro valore personale ai risultati che riuscivamo ad ottenere sul nostro percorso terapeutico, di crescita personale o spirituale. Chi noi eravamo, è dunque stato confuso con ciò che eravamo o meno in grado di fare.
Inizialmente, paragonandoci agli altri e vedendoli apparentemente stare meglio di noi, una voce affermava che:
“Se sei come loro, vai bene; altrimenti, no.”
Oggi, dopo questi percepiti fallimenti, questa voce afferma:
“Se questa tecnica funziona sugli altri, ma tu non sei in grado di utilizzarla per stare meglio, allora sei tu che non sei all’altezza”
Se prima il nostro valore era subordinato a quanto stavamo bene o male rispetto agli altri, ora il nostro valore è vincolato a quanto efficacemente siamo in grado di applicare la tecnica di turno. Ed in questa ottica, utilizziamo un valore numerico per misurare noi stessi e, in base alla disciplina scelta, affermiamo internamente che “io valgo se:
Riesco a meditare profondamente per tot minuti al giorno;
Riesco a perdere tot kg;
Riesco a produrre tot opere artistiche al mese;
Riesco a trovare tot clienti;
Riesco ad allenarmi tot ore alla settimana;
Riesco ad aumentare di tot il mio guadagno economico;
Riesco ad eliminare tot abitudini negative dalla mia vita…”
…e via discorrendo.
Quel “tot” diventa il valore numerico del nostro valore personale.
Nel momento in cui non riusciamo a portare a termine questi obiettivi, ci sentiamo male. Diamo la colpa del nostro malessere al fatto che non siamo riusciti nel nostro intento. Ci diciamo: “Se fossi riuscito veramente a mettere in pratica quella tecnica, allora adesso starei meglio”. Ma naturalmente non è quella la causa. Il motivo per cui stiamo male è il fatto che inizialmente avevamo una malessere dal quale volevamo fuggire. Oggi questo disagio è diventata una sofferenza perché, oltre al malessere stesso, ci stiamo dando contro perché ci giudichiamo in quello che percepiamo come un nostro fallimento nel non essere riusciti a sbarazzarcene. Abbiamo vincolato il nostro senso di valore al raggiungimento dei nostri obiettivi. Abbiamo confuso chi noi siamo come individui con ciò che siamo o non siamo riusciti a fare. Abbiamo confuso l’essere con il fare.
E dunque, qualora ci fosse un malessere che stai vivendo in questo momento della tua vita, prova a domandarti:
“Ma sto veramente male perché non sto raggiungendo gli obiettivi che mi sono mess’in testa, oppure sto male perché ho deciso che valgo solo se faccio tutte queste cose e, nel momento in cui non ci riesco, mi colpevolizzo e mi giudico?”
Abbiamo dunque confuso gli obiettivi con il reale benessere. Ci siamo convinti che il raggiungimento di questi traguardi sia il punto d’arrivo dove finalmente saremo felici. E questo è ciò che ci fa soffrire: la convinzione che non potremo stare bene finché non avremo raggiunto questi risultati. Ogni momento che trascorriamo viaggiando verso queste mete lo facciamo diventare un momento di sofferenza perché siamo lontani da ciò che siamo convinti ci darà la contentezza che da sempre cerchiamo.
È per questo che così spesso molliamo per dedicarci ad altro e distrarci da questo tormento! Quella pigrizia di cui tanti di noi soffrono, non è altro che questo: la paura che non ce la faremo mai a raggiungere questi obiettivi, il dolore profondo per la realizzazione della nostra inadeguatezza e dunque la rassegnazione che ci porta dire:
“Ma chi me lo fa fare? tanto vale distrarmi, fare altro, così non penso a quanto mi fa male sapere che non potrò mai essere felice”.
Quante volte abbiamo raggiunto uno di questi obiettivi, solo per renderci conto che, di fatto, questo raggiungimento non ci ha conferito istantanea e soprattutto permanente felicità? Dopo un breve momento di euforia, magari durato qualche giorno, ci siamo resi conto che, poco alla volta, quel senso di irrequietezza per una profonda mancanza ricominciava ad emergere da dentro di noi. E piuttosto che fermarci ad osservare questo processo e notare quanto questo andasse a contraddire quella credenza che il raggiungimento dell’obiettivo ci avrebbe resi felici, ci siamo subito messi alla ricerca di una nuova meta da raggiungere.
Ci siamo convinti che forse avevamo scelto il traguardo sbagliato ed era un altro quello che ci avrebbe resi felici. Se davvero ci fossimo fermati un attimo a respirare, però, ci saremmo resi conto che questa non era altro che un’illusione. In realtà non c’era nessun obiettivo che, una volta raggiunto, ci avrebbe resi felici.
Apro una piccola parentesi in merito alla parola “felicità”.
Quando parliamo di “felicità”, a livello inconscio spesso lo facciamo in termini un po’ infantili, che ci portano a vederla come quello stato di beatitudine assoluta, nel quale non proviamo alcun turbamento e nulla più ci tocca negativamente. Che sia rivolto ad una relazione, un lavoro, un obiettivo, c’è una parte bimba di noi che vive questo anelito aspettandosi di raggiungere questo stato di benessere totale. Una visione un po’ più realistica ed adulta di questo concetto di felicità riguarda quello stato di contentezza che ci rende sereni e quanto più possibile in pace con la realtà delle cose. Queste due prospettive possono alternarsi e convivere dentro di noi e ritengo sia importante notare su quale delle due tendiamo più a puntare quando pensiamo alla felicità. In questo episodio, nel parlare di felicità faccio riferimento più ad uno stato di serena contentezza.
le lezioni imparate
Quella voce che ci paragona agli altri e che ci dice che non andiamo bene così come siamo, è la stessa voce che costantemente ci spinge a superare i nostri limiti. Il più delle volte, però, superare i nostri limiti significa non rispettarli, vuol dire non concederci il riposo necessario, vuol dire metterci in situazioni che ci causano ansia, vuol dire frequentare persone che non sono in armonia con chi noi siamo. Questo non ci fa bene, perché lo stress a cui sottoponiamo noi stessi mettendoci in queste situazioni, prima o poi si manifesterà a livello fisico, emozionale e psicologico.
Questa parte di noi parte dal presupposto che i limiti sono difetti che ci impediscono di essere felici. Se invece scegliamo di lasciare andare questa credenza, abbiamo allora la possibilità di abbracciare la verità, ovvero che i nostri limiti sono in realtà ciò che ci rende umani. Nei nostri limiti c’è la nostra vulnerabilità, c’è la nostra fragilità e tutto ciò che ci rende autentici e che meglio di qualsiasi altra cosa ci permette di entrare in contatto con gli altri.
Non solo, ma i nostri limiti sono anche ciò che ci permette di imparare dagli eventi della vita. Quando cadiamo, è stando a terra che impariamo la maggior parte delle lezioni più importanti. Ma nella nostra vita, quando siamo giù, quanto siamo in accettazione del nostro stato e quanto invece etichettiamo le nostre cadute come fallimenti? Quanto vogliamo rialzarci più in fretta possibile e scappare da quella condizione e quel sentire? Quanto siamo capaci di prenderci il tempo necessario per restare a terra, comprendere perché siamo caduti, scegliere con cura la nostra prossima direzione in base alla lezione imparata poc’anzi e alzarci con calma, pronti a riprendere il nostro cammino con nuova chiarezza? Quanto sappiamo vivere con amore e dignità i lividi e le cicatrici delle nostre cadute? La risposta a tutte queste domande è essenziale per trarre il massimo beneficio da questo aspetto della nostra vita.
A volte possono esserci difficoltà a livello di salute, potremmo avere una depressione post-parto, possiamo avere squilibri a livello ormonale, complicazioni dovute all’età, difficoltà familiari, sul lavoro… insomma, gli ostacoli sul nostro cammino possono essere infiniti. Se di fronte ad ogni ostacolo entriamo in sofferenza perché siamo convinti che esso ci impedisce di essere sereni, allora è naturale che viviamo male tutto il processo. Questa accettazione parte dunque da un cambio di prospettiva, cominciando dal considerare la possibilità che non sia l’obiettivo che ci renderà felici, quanto il come sceglieremo di vivere il viaggio, a prescindere da quanto tempo richiederà.
Potremmo pensare che questo ci porti a diventare ulteriormente pigri e a non provarci nemmeno più a raggiungere i nostri obiettivi. Ma su questo mi piacerebbe farti una domanda un po’ provocatoria: e se così fosse? Cioè, se veramente rinunciassimo a raggiungere un certo obiettivo, sarebbe davvero così male?
Facciamo un piccolo esercizio: pensa ad un obiettivo che credi ti renderà felice e verso il quale lavori da un po’. Pensa a qualcosa su cui hai investito grosse energie ed aspettative, che sia sul fronte lavorativo, relazionale, economico o di vita. Ce l’hai? Ok, ora rispondi a questa domanda:
Preferisci raggiungere questo obiettivo o preferisci essere felice?
Ora nota che cosa stai provando. Come ti fa sentire questa domanda? Ti infastidisce? Ti fa arrabbiare? La trovi una domanda stupida e priva di senso perché entrambi gli elementi della mia domanda, l’obiettivo e la felicità, per te rappresentano la stessa cosa? Oppure ti apre ad una possibilità alla quale non avevi pensato, ovvero che possano essere due cose diverse? Semplicemente nota come ti senti. Questo ti può dare un utile indicatore su come vedi le due cose: il percorso e l’obiettivo, il cammino e la meta.
Considera la possibilità che se lavorare verso il raggiungimento di quell’obiettivo non ti dà già serenità, allora stai riponendo troppe aspettative sull’obiettivo stesso, perdendo l’opportunità di goderti la tua vita, che si svolge prevalentemente durante il viaggio. Un eccessivo focus sui nostri obiettivi fa sì che il processo di crescita personale e la conseguente trasformazione diventino un pretesto per non accettare chi noi siamo ora.
Non siamo dei robot, non possiamo semplicemente eseguire operazioni a comando. La vita ha un modo tutto suo di dettare tempi e ritmi. A volte la strada è lunga in maniera esasperante, altre volte ci troviamo lì in un attimo. Di fatto è qualcosa che non possiamo prevedere e, men che meno, controllare. Più ci opponiamo a questo ritmo naturale, più soffriamo.
Possiamo svegliarci alla 5 tutte le mattine, ma se le parole per quel libro, la pace derivante da quella pratica meditativa, le note per quel brano o le idee per quel quadro non ci sono, non ci sono e basta. Possiamo avere una disciplina di ferro, ma se non è il momento, non è il momento. Dobbiamo darci il permesso di essere umani.
A volte quel libro non è pronto per essere scritto perché non abbiamo ancora incontrato l’ispirazione per il personaggio principale. A volte abbiamo bisogno di ancora un paio di anni di esperienza di vita prima che le nostre opere abbiano l’autenticità che permetterà ad altri di sentirle vere dal profondo. A volte non stiamo incontrando la persona giusta perché ciò che abbiamo bisogno di comprendere di noi stessi può solo essere compreso attraverso ancora un po’ di solitudine. A volte la pace nella meditazione non arriva perché dobbiamo ancora elaborare certe tematiche a livello psicologico. A volte siamo avvolti dalla tristezza perché è l’evento cardine su cui costruiremo la prossima fase della nostra vita.
Dobbiamo voler cambiare non perché siamo sbagliati così come siamo, ma perché sentiamo che trasformare alcune parti di noi ci porterà a vivere meglio la nostra vita e le nostre relazioni. Ma la possibilità di stare bene con noi stessi, l’abbiamo da subito. L’accettazione di chi noi siamo ora non può essere subordinata a come noi siamo ora. Se il processo di crescita personale parte dal presupposto che c’è qualcosa che non va in noi, allora sarà faticoso e pieno di sofferenza, perché saremo costantemente messi davanti a ciò che dentro di noi non dovrebbe essere. È per questo che è così importante portare compassione e accettazione incondizionata a noi stessi, soprattutto durante il lavoro di crescita personale, perché nel lasciare emergere aspetti di noi che prima potevamo stare ignorando, dobbiamo poterla accogliere amorevolmente, dando il benvenuto ad ogni sfaccettatura di chi noi siamo.
È inutile raccontarcela considerandolo solo un cliché trito e ritrito: di fatto siamo sereni e felici quando ci sentiamo amati per quelli che siamo. Punto. E fintanto che non siamo in grado di amarci per quelli che siamo, non riusciamo ad essere felici o a fare entrare l’amore degli altri. È difficile e richiede lavoro, è vero, ma è possibile e soprattutto ne vale assolutamente la pena.
Possiamo rimproverarci per i nostri fallimenti, oppure amarci per la perseveranza nel continuare a provarci. È una nostra scelta che però avrà un impatto enorme sul nostro benessere. Possiamo andare avanti a ripetere a noi stessi il verbo “devo” ed inevitabilmente sentirci inadeguati, oppure possiamo portare verso noi stessi la pazienza che avremmo con qualcuno che amiamo veramente.
La fretta non è altro che l’ansia del momento presente che la nostra mente ha deciso non andare bene così com’è, dunque non aiuta in alcun modo. Per vivere serenamente il nostro percorso, dobbiamo sviluppare quella stessa pazienza che avremmo con un bambino, al quale non diremmo mai che si deve dare una mossa a crescere. È un processo che non si può affrettare, si può solo accompagnare amorevolmente. Al limite, attraverso il lavoro terapeutico, possiamo portare chiarezza, rimuovere gli ostacoli da noi stessi generati nel tempo e creare le migliori condizioni possibili perché questa trasformazione possa avvenire in maniera più fluida possibile. Ma nulla più.
Qualunque tematica interna sulla quale possiamo stare lavorando, verrà trasformata nel momento in cui ci avremo messo il lavoro necessario e sarà passato il tempo necessario. Le nostre aspettative non ci aiutano, poiché anch’esse sono la non accettazione di ciò che proviamo internamente nel momento presente. Il nostro dolore non indica che dove ci troviamo è sbagliato, ma al limite che è necessario o auspicabile un cambiamento. Altre volte, il dolore è semplicemente ciò che dentro di noi chiede di esistere e di scorrere liberamente. E come tutto, non durerà per sempre.
Ognuno di noi ha vissuto traumi e ferite che oggi hanno un impatto sulla nostra vita. Queste tematiche irrisolte sono fonte di malessere e difficoltà nel nostro quotidiano. È indubbio che lavorare, magari con una figura terapeutica, sull’elaborazione di queste problematiche che ci affliggono sia sano e ci porti un domani a vivere meglio. Al contempo, questo processo può richiedere mesi, anni o anche decenni. Se riponiamo ogni aspettativa in quel momento nel futuro, viviamo inevitabilmente male tutto il periodo intermedio.
La vita è imprevedibile e, soprattutto, ineluttabile: non possiamo prevederne i movimenti e, la maggior parte delle volte, non possiamo in alcun modo opporci ad essi. Siamo come barchette a remi che navigano su un enorme fiume. È impensabile e folle voler cambiare il fiume. Se ci illudiamo di poterlo dominare, questo non fa altro che aumentare la nostra ansia e senso di impotenza di fronte a qualcosa di molto più grande di noi.
Prima lasciamo andare l’aspettativa di poter governare la vita, prima smettiamo di soffrire. Ciò che possiamo controllare, però, è come scegliamo di relazionarci a ciò che la vita ci offre. La chiave di un’esistenza felice risiede nella nostra capacità di arrenderci con serenità a questo fiume che ci trasporta in ogni momento, imparando a remare quel poco che basta per non andare a sbattere contro le rocce, ma altrimenti abbandonandoci all’amorevole flusso che in ogni momento ci accompagna e ci sostiene.
Sentirci rincuorati della presenza stessa del fiume e dell’acqua tutto intorno a noi è la chiave che alimenta quella fiducia, che qualcuno potrebbe chiamare fede, che va tutto bene e che in ogni momento siamo esattamente dove dobbiamo essere.